
Sono riconoscente a Federico Ferrari per aver accettato il dialogo sulle questioni sollevate nella mia recensione al suo libro. La sua risposta ha riaperto temi e problemi su cui rifletto da tempo e mi offre altra materia buona da pensare. Vorrei però affrontare subito alcuni punti, per chiarire possibili equivoci.
L’antinomia critica è una risposta acuta, non solo elegantemente in linea con la testata del sito su cui è pubblicata, ma anche in sintonia col cuore stesso della questione estetica, che nasce proprio all’insegna di una famosa antinomia, quella kantiana del gusto (che però Kant, a modo suo, risolveva).
Per uscire da una contraddizione si possono prendere in linea di massima due vie: si può dimostrare che una delle due tesi contrapposte (o entrambe) va in realtà riconcettualizzata in modo tale da dissolvere la contraddizione; oppure si può accettarla sostenendo che in realtà è un’antinomia irrisolvibile. Ferrari ha scelto la seconda: tra visione e critica c’è un’antinomia inevitabile, anzi doverosa, visto che conclude il suo pezzo suggerendo, con tono prescrittivo, che non si debba andare oltre questa «oscillazione antinomica».
Io penso invece che questa antinomia critica, con la sua affascinante cogenza, derivi da un certo modo di intendere il linguaggio in generale e il suo rapporto con la percezione. Nel suo testo Ferrari punta soprattutto a ribadire la differenza tra il suo modo di intendere la critica e il modo in cui la intende chi, come me, adotta una posizione “ermeneutica”. E la sua argomentazione è una descrizione metaforica del sapere e del linguaggio che la critica dovrebbe usare per parlare dell’opera in modo da non impedirne la visione.
Prima di affrontare questo tema, vorrei però precisare un paio di punti in cui, nonostante le apparenze, mi pare che le nostre posizioni siano molto vicine, se non coincidenti. Condivido innanzitutto il fastidio per l’eccesso di comunicazione, per quell’ipertrofia di discorsi che circondano l’arte contemporanea e che troppo spesso hanno solo una funzione di packaging più o meno implicita. Condivido anche l’idea che «il sapere dell’opera» sia esemplare, perché è proprio questo che intendo con paradigmatico. Il senso di paradigma a cui alludevo (e che non ho approfondito, inducendo probabilmente all’equivoco) non è tanto quello che Kuhn applica alle rivoluzioni scientifiche nel suo testo fondamentale (anche se nel Poscritto ci si avvicina), né quello che Heinich ha mutuato da Kuhn. Parlo proprio dell’esempio di cui non è possibile dare una legge (Kant): il sapere dell’opera è paradigmatico (o esemplare) perché è analogico e quindi non si dà come legge, né come modello esplicito o esplicitabile. Quando la critica “visionaria-antinomica” di Ferrari sceglie un’opera o una costellazione di opere fa precisamente questo: indica l’opera come esempio o paradigma di altre opere, cioè propone un’ipotesi di interpretazione basata su analogie. Il sapere paradigmatico non è una sussunzione sotto qualche regola, nè la dimostrazione della coincidenza con un modello precostituito.
Tornando al tema principale, dal mio punto di vista quella che Ferrari vede come un’antinomia è la naturale tensione insita nel rapporto assai complesso e controverso che esiste tra percezione e linguaggio. La differenza tra i nostri punti di vista dipende in primo luogo dal modo in cui intendiamo questo rapporto, e in particolare dal modo assai diverso in cui intendiamo i concetti di interpretazione e di significato.
Per me il significato non è il lemma del dizionario: è il risultato di un’organizzazione categoriale del mondo basata su un’ipotesi interpretativa. Ne risulta che linguaggio e percezione sono inestricabilmente intrecciati. Quando guardiamo le cose vediamo anche significati, perché la percezione interpreta il mondo facendo ipotesi semantiche; e perché il significato, inteso in questo modo, ha anche una dimensione percettiva. Persino quando una figura, per quanto indefinita, si stacca da uno sfondo attirando la nostra attenzione, si mettono in azione ipotesi interpretative, meccanismi semantici elementari che si basano essenzialmente su analogie.
Quanto all’interpretazione di un’opera d’arte, per me non è l’applicazione di un metodo valido a priori, la soluzione di un enigma o la scoperta di un codice nascosto che renda leggibile un testo. L’interpretazione, anche la più profonda, non esaurisce mai l’opera d’arte. Anzi, si può dire che nemmeno tutte le migliori interpretazioni messe assieme arriveranno mai ad esaurire l’opera, non solo per l’ovvia ragione che il linguaggio non può sostituire la visione, ma anche perché l’interpretazione è sempre un’ipotesi e le opere d’arte sono sempre “aperte” (il che non significa comunque che non ci siano limiti alle interpretazioni).
Quando, seguendo Arthur Danto, uso l’espressione «significato incarnato» in riferimento all’opera d’arte, sto sintetizzando in una formula una concezione complessa in cui “significato” va inteso come interpretazione in senso molto lato, cioè come quell’«atmosfera di teoria e storia dell’arte» (Artworld) in cui rientra l’artista, la sua vita, la sua ouvre, il contesto storico-sociale-culturale, oltre alle interpretazioni e agli effetti prodotti dall’opera; e “incarnato” indica che quel significato è inseparabile dal corpo significante (l’oggetto, l’evento, il segno), il quale è sempre necessariamente presente, anche nelle modalità più inopinate dell’arte contemporanea.
Per me l’opera incarna un significato perché è un’unità inscindibile di materia “formata” e interpretazione “formante”. E questo significato-interpretazione non è qualcosa di esterno e successivo al lavoro dell’artista: è all’opera, in modi sfuggenti e più o meno inconsapevoli, già nel suo lavoro e ha un carattere “asintotico”. Lo stesso carattere che si ritrova, riflesso specularmente, nel lavoro del critico-interprete, che in un certo senso cerca di ricostruire in via ipotetica il processo che ha condotto all’opera finita (ma sempre “aperta”).
A questo punto credo sia evidente che per me questi significati-interpretazioni non rendono invisibile l’opera «per eccesso di luce», né sono qualcosa di posticcio che si aggiunge ad essa creando un diaframma che ostacola lo sguardo. Scaturiscono da un’attenzione visiva e concettuale assieme, perché l’opera è allo stesso tempo corpo e mente, visione e significato. La critica non immerge l’opera in una luce onnipervasiva e appiattente, ma aiuta ad apprezzare meglio anche «la sua luce nera, il suo sapere umbratile», grazie a uno sguardo pensante o a una visione potenziata.
La funzione della critica, scrive Danto «è quella di dotare lo spettatore delle informazioni necessarie a rispondere alla potenza dell’opera». La faccio mia, sostituendo l’infelice espressione “informazioni necessarie” con una meno scientistica, come ad esempio “suggestioni utili”.
«La parola critica», scrive Ferrari, «nasce dal sapere, ma assume una pregnanza solo quando è capace di ridare al sapere il suo sapore». (Noto en passant che, evocando il nesso tra sapere e sapore, questo passaggio scoperchia il pozzo senza fondo della relazione antinomica per eccellenza: quella tra conoscenza e piacere che Agamben individua sotto quel concetto di gusto da cui nasce l’intera questione estetica. Come nota Kant all’inizio della terza critica: «Questa relazione è proprio ciò che vi è di enigmatico nella facoltà del giudizio»).
Confrontando la frase di Danto con quella di Ferrari, credo sia possibile individuare tanto un punto ideale di convergenza, quanto un punto profondo di divergenza. La convergenza è nel considerare la critica come un sapere e le sue parole sapienti come uno strumento il cui scopo è mettere lo spettatore nella condizione di sperimentare la potenza o il sapore dell’opera d’arte.
La divergenza è nel tipo di sapere che la critica ideale offre. Per Ferrari è un sapere sapienziale e fondamentalmente esoterico, quasi un esercizio spirituale che prepara al «balenare dell’invisto» di una realtà indicibile posta oltre o sotto la dimensione semiotico-culturale e che solo l’arte migliore riesce a far intravedere.
Per me è un sapere essoterico che fa necessariamente parte della cultura, perché l’arte non è che il bordo in movimento della cultura, la membrana elastica della semiosfera. E l’oltre a cui l’arte mira non è che questa inesauribile elasticità della semiosfera in continua espansione.
La divergenza nel tipo di sapere comporta anche una differenza nel tipo di scrittura che la critica ideale deve far propria. Per Ferrari, a giudicare dalle metafore che usa e dagli esempi che propone (Anedda, Campo, Ceronetti, Manganelli), è necessaria una scrittura fondamentalmente poetica o comunque una prosa d’arte capace di porsi «nel cono d’ombra dell’opera». Non una «parola definitoria, ma risonante, eco distorcente di una distorsione originaria che l’opera testimonia». Al fondo mi pare faccia capolino l’idea romantica che la vera critica d’arte dev’essere essa stessa un’opera d’arte.
Sono convinto anch’io che la qualità della scrittura non possa che giovare all’interpretazione critica. Come sono convinto che critica interpretante e critica risonante siano entrambe utili e legittime, e che perciò l’una non sia inadeguata e l’altra adeguata. Credo tuttavia che sia più importante far valere la funzione “illuministica” della critica, il cui compito è avvicinare il pubblico all’arte migliore. Perciò in genere preferisco quella critica in cui la scrittura è al servizio dell’interpretazione (esempio paradigmatico: La squadratura di Italo Calvino che interpreta le opere di Giulio Paolini), alla critica in cui l’opera visiva diventa uno spunto per un’opera letteraria (esempio paradigmatico: i Salons di Giorgio Manganelli).
In quest’ultima vedo il rischio che la qualità dell’«eco distorcente» finisca per distrarre l’attenzione e magari rubare la scena all’opera. Questo rischio, lo ammetto, vale anche per la critica interpretante; in questo caso però il difetto non dipende dalla qualità, ma da un difetto dell’interpretazione, che diventa sovra-interpretazione, deriva decostruzionista nelle mani dei «talmudisti delle arti visive», come li chiama Ferrari.
Vorrei concludere con un aforisma che mi sembra sintetizzi bene le convergenze (o divergenze) parallele dei nostri punti di vista. Susan Sontag concludeva il suo famoso saggio Contro l’interpretazione con un frase che Ferrari sicuramente sottoscriverebbe: «Anziché di un’ermeneutica, abbiamo bisogno di una erotica dell’arte». Visto che l’erotismo sta tra le orecchie almeno quanto sta tra le gambe, io direi piuttosto che abbiamo bisogno di un’ermeneutica migliore. E quindi più erotica.
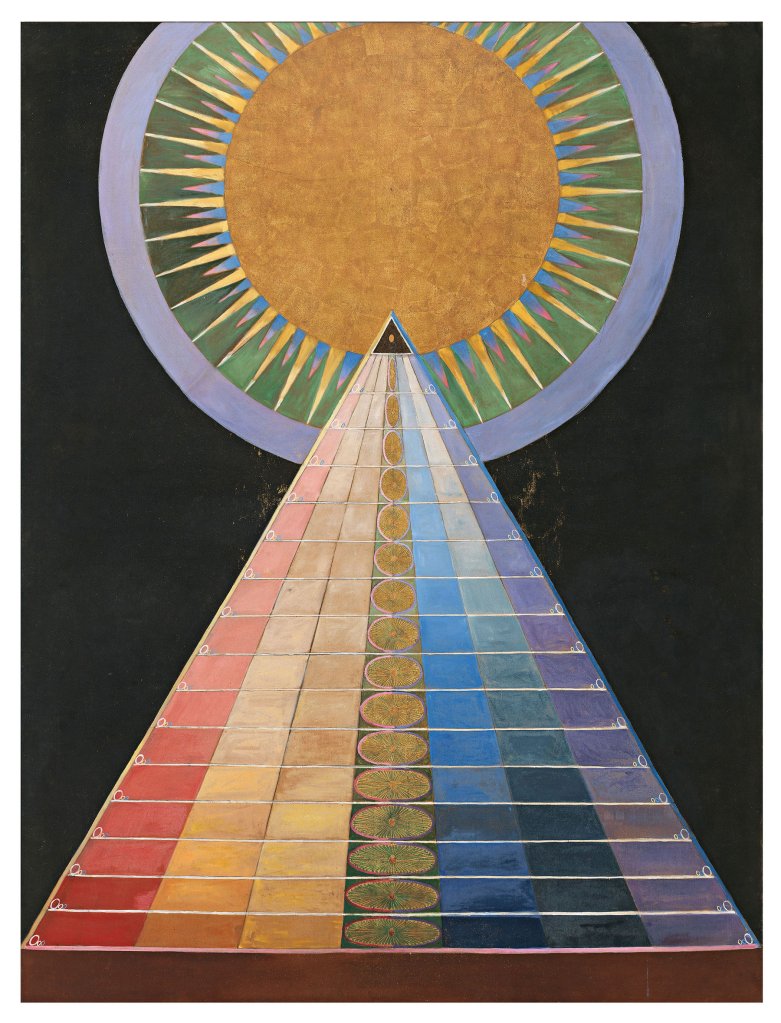
Postscriptum
Il dialogo tra me è Federico Ferrari è continuato con un breve scambio di email, che sintetizzo qui di seguito.
FF: «Per me, l’opera è esattamente quel che dici, uno “spunto”, solo che io non lo direi così, ma direi che l’opera è una “porta”. Non mi interessa l’opera in sé e, di conseguenza, non temo di “rubarle la scena” o di metterla in ombra. L’opera, come le parole critiche, serve solo per accedere a una dimensione ulteriore. Per me, il resto è, nel migliore dei casi, cultura, nel peggiore, feticismo. E, in fondo, provo disgusto per il secondo e poco interesse per la prima. La distanza che ci separa sta tutta qui e non è poca, ovviamente. […] Mi ha fatto sorridere che tu abbia citato uno scritto su Paolini perché proprio questa estate ho ricevuto una lettera di Giulio, estremamente commovente, in cui mi diceva di essersi sentito molto raramente così compreso da qualcuno come nello scritto che mi aveva chiesto di redigere per il catalogo di una sua mostra. Lo dico, non certo per autoincensarmi, ma perché spesso esistono delle ironie della storia che aiutano a pensare: Paolini l’analitico che ama la visionarietà critica».
LB: «Se per te l’opera è una porta per una dimensione ulteriore, la critica è del tutto inutile. O meglio: diventa tutt’altro. Se è così, allora mi pare che anche l’antinomia svanisca: l’opera visiva e la sua eco letteraria sono semplicemente due tentativi di guardare oltre quella porta. E se non c’è critica, non c’è nemmeno una questione da discutere. […] In merito a Paolini, non mi sorprende la sintonia che egli sente per il tuo modo di pensare l’arte. Trovo che ci sia qualcosa di paradossale (antinomico?) nel rapporto tra le cose che Paolini ha fatto e il senso del suo fare che emerge dai suoi scritti (e che evidentemente coincide con la tua idea di arte). Fin dalla sua apparizione all’inizio del ‘900, l’astrazione più radicale appare in bilico tra la semiotica e la mistica. Io tuttavia continuo a pensare che quel testo di Calvino sia una delle migliore “critiche interpretanti” del periodo più importante e creativo di Paolini».
FF: «Non penso che la parola critica sia inutile. Non lo credo, da una parte, molto semplicemente, perché continuo a scrivere e, dall’altra, perché il fatto che l’opera sia una porta non significa che questa porta sia aperta. La critica ha il compito, quando le riesce, di aprirla o di indicare una via per entrare. Per il resto, faccio salvo quanto ti ho già scritto. Anzi, ti invio questo articolo molto vecchio, nel quale, in modo molto brusco, dicevo già molte cose a riguardo».
LB: «Il modo brusco è anche un modo illuminante. Ora mi rendo conto che per te sia l’arte che la critica sono forme della mistica. A questo punto, l’unico esito possibile del nostro dialogo sarebbe una conversione».
In mancanza, le nostre divergenze rimarranno divergenti.
